 «Altro che falsi, quei titoli sono veri e ancora validi, ecco perché fanno tanta paura agli americani. Al mio assistito li ha consegnati un cittadino spagnolo con tanto di procura a vendere, doveva provare a piazzarli sul mercato dietro riscontro di una percentuale». A parlare è l’avvocato dell’agricoltore viterbese, fermato dalla Guardia di Finanza il 21 aprile scorso nel capoluogo della Tuscia, mentre se ne andava in giro sulla sua macchina con una valigetta piena zeppa di titoli di Stato e certificati di deposito in oro statunitensi per un valore di quasi 4 miliardi di euro. «Il mio assistito – spiega a Il Punto l’avvocato Franco Taurchini – aveva con sé anche alcuni documenti che certificano l’autenticità dei titoli e dei certificati di deposito. Glieli aveva affidati uno stimato imprenditore della Costa Brava, che tra l’altro ha da tempo intentato causa alla Federal Reserve. Sono autentici, e visto il loro valore, è ovvio che le autorità americane si affrettino a dichiararli falsi».
«Altro che falsi, quei titoli sono veri e ancora validi, ecco perché fanno tanta paura agli americani. Al mio assistito li ha consegnati un cittadino spagnolo con tanto di procura a vendere, doveva provare a piazzarli sul mercato dietro riscontro di una percentuale». A parlare è l’avvocato dell’agricoltore viterbese, fermato dalla Guardia di Finanza il 21 aprile scorso nel capoluogo della Tuscia, mentre se ne andava in giro sulla sua macchina con una valigetta piena zeppa di titoli di Stato e certificati di deposito in oro statunitensi per un valore di quasi 4 miliardi di euro. «Il mio assistito – spiega a Il Punto l’avvocato Franco Taurchini – aveva con sé anche alcuni documenti che certificano l’autenticità dei titoli e dei certificati di deposito. Glieli aveva affidati uno stimato imprenditore della Costa Brava, che tra l’altro ha da tempo intentato causa alla Federal Reserve. Sono autentici, e visto il loro valore, è ovvio che le autorità americane si affrettino a dichiararli falsi».
Il 70enne Andrea Cherchi, così si chiama l’agricoltore finito sotto inchiesta per il contenuto di quella valigetta, non è stato arrestato (come chiarisce il suo legale), anche se nei suoi confronti è stato ipotizzato il reato di introduzione nel territorio dello Stato di monete e titoli presumibilmente falsi. In passato l’agricoltore viterbese di origini sarde aveva già avuto molti problemi con la giustizia, ed è la sua fedina penale a raccontare tutto il resto: rapina, estorsione, reati contro il patrimonio, traffico di stupefacenti e riciclaggio di denaro. Gli investigatori pare indagassero sul suo conto da mesi, anche se la genesi dell’indagine Million dollar, che ha portato al sequestro della valigetta contenente il tesoretto in titoli americani, è ancora poco chiara, così come tutto ciò che ruota attorno a questa spy story. Stando a quanto ha fatto sapere la Guardia di Finanza i documenti sequestrati all’agricoltore sono ritenuti «di dubbia provenienza», cioè sarebbero falsi. I titoli di credito americani, emessi “al portatore” dalla Federal Reserve negli anni Trenta, che l’uomo aveva con sé valevano complessivamente 1,5 miliardi di dollari e oltre 3 miliardi di euro gli altri certificati di deposito, per circa mille tonnellate di oro, trovati in suo possesso. Secondo le fiamme gialle i titoli erano destinati a garantire prestiti «ovvero opache transazioni finanziarie internazionali», così come altri documenti finanziari e scritture notarili che Cherchi aveva in auto nel momento in cui la finanza lo ha bloccato a Viterbo. Sull’autenticità dei documenti sono ancora in corso accertamenti, cui stanno collaborando i funzionari della Banca centrale americana e dell’Ambasciata degli Stati Uniti. «Accertamenti - spiega una nota diffusa dalle fiamme gialle - volti a verificare l’autenticità, la natura e la provenienza dei titoli, nonché la loro destinazione ed eventuali collegamenti dell’uomo con organizzazioni criminali».
Via Veneto conferma. Ecco quanto ha riferito a Il Punto il portavoce dell’Ambasciata americana di Roma: «Per quanto riguarda le recenti notizie di falsi/fittizi titoli di Stato degli Stati Uniti, posso solo dire che i Servizi segreti stanno collaborando regolarmente con i funzionari italiani delle forze dell'ordine e ci complimentiamo con la polizia italiana e i magistrati per la collaborazione. I 6.000 miliardi di dollari in titoli sequestrati a febbraio erano fittizi e il Servizio segreto ne ha dato conferma alle autorità italiane». Secondo quanto ha appreso Il Punto, gli esperti del U.S. Secret service, dopo aver visionato i titoli sequestrati a Cherchi, hanno trasmesso alla Guardia di Finanza un dettagliato rapporto in cui si conferma, come avvenuto in occasione di altre decine di sequestri di questo tipo, che quei titoli sono «fittizi», cioè falsi. La verità, secondo le autorità americane, è nelle loro caratteristiche: colori sbagliati, tagli desueti, carta e inchiostro di produzione successiva agli anni Trenta, varie imperfezioni e iscrizioni mai usate nelle emissioni reali. Senza tralasciare – come più volte segnalato dalla stessa Federal Reserve – che l'esagerato taglio dei bond sequestrati (1 miliardo di dollari) è di gran lunga superiore a quello massimo (100.000), effettivamente utilizzato dal governo statunitense, che, tra l’altro, nel ‘34 non immise sul mercato obbligazioni di questo tipo.
Prima del blitz della Guardia di Finanza a Viterbo, anche la Direzione distrettuale di Potenza aveva messo a segno un colpo analogo. Proprio nel febbraio scorso, il 17, il Ros dei carabinieri nell’ambito dell’operazione Vulcanica aveva sequestrato a Zurigo altri titoli Usa del valore di 5.975 miliardi di dollari. In quell’occasione era finito in manette, insieme ad altre 7 persone, un promotore finanziario di Codogno, che interrogato aveva anch’egli dichiarato che quei titoli erano autentici ma scaduti. Il professionista codognese, secondo gli inquirenti della Dda di Potenza, era l’intestatario del contratto di deposito in Svizzera delle casse che contenevano i bond, aperte dai militari del Ros grazie alla collaborazione dell’istituto di credito elvetico che le custodiva. I titoli erano stati emessi nel 1934 (come quelli sequestrati all’agricoltore viterbese) e avevano una validità di trentatré anni. I pm Francesco Basentini e Laura Triassi sono arrivati alle tre casse partendo dalla Basilicata e indagando su faccende di usura e mafia. Il prezioso contenuto dei bauli avrebbe raggiunto Zurigo dopo un lungo peregrinare: prima Roma, poi Londra, Hong Kong e infine la Svizzera, e a veicolare fin lì i titoli sarebbe stata una fiduciaria elvetica fondata all’indomani della seconda guerra mondiale. All’interno di ognuna delle tre casse gli investigatori hanno trovato, ben custoditi dentro dei cilindri di piombo, anche una copia del trattato di pace di Versailles (1919). E quei Bond, secondo il gruppo di falsari che stava tentando di immetterli sul mercato, rappresentavano la «riparazione» delle potenze vincitrici della prima guerra mondiale per i danni causati all’Europa. Le tre casse di legno erano chiamate con il nome in codice mother box, pesavano oltre un quintale l’una e avevano impresse sulla parte superiore le scritte in bronzo “Chicago” e “Federal Reserve”. Al loro interno i titoli erano a loro volta stipati e accuratamente catalogati in piccoli box di ferro in grado di ospitare 250 documenti ciascuno. Dopo una prima analisi, gli inquirenti hanno potuto accertare che i bond erano stati trattati con la paraffina, per garantire una migliore conservazione, ed erano di ottima fattura, ma certamente falsi secondo la perizia trasmessa al Ros dagli esperti dell’ufficio di Roma dell’U.S. Secret service. Secondo gli investigatori l’organizzazione, di cui facevano parte oltre il promotore finanziario di Codogno anche tre piemontesi, due romani, un lucano e un siciliano, avrebbe comunque tentato di “piazzare” titoli americani simili a quelli sequestrati a Zurigo, anche avviando trattative con «alcune non ben individuate autorità americane», interessate, guarda caso, a «intercettare» il tesoro prima che fosse messo in circolazione.
di Fabrizio Colarieti per Il Punto [pdf]
 ROMA - Nel cielo di Ustica la notte del 27 giugno 1980 ci fu un’azione di guerra. E in questo scenario il Dc9 della compagnia Itavia, che andava da Bologna a Palermo, fu abbattuto da un missile o a causa di una quasi collisione con un altro aereo mai identificato. E’ questa la conclusione cui è giunto il 10 settembre il giudice della terza sezione civile del Tribunale di Palermo, Paola Proto Pisani,
ROMA - Nel cielo di Ustica la notte del 27 giugno 1980 ci fu un’azione di guerra. E in questo scenario il Dc9 della compagnia Itavia, che andava da Bologna a Palermo, fu abbattuto da un missile o a causa di una quasi collisione con un altro aereo mai identificato. E’ questa la conclusione cui è giunto il 10 settembre il giudice della terza sezione civile del Tribunale di Palermo, Paola Proto Pisani, 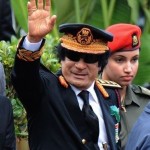 Una pioggia di missili
Una pioggia di missili